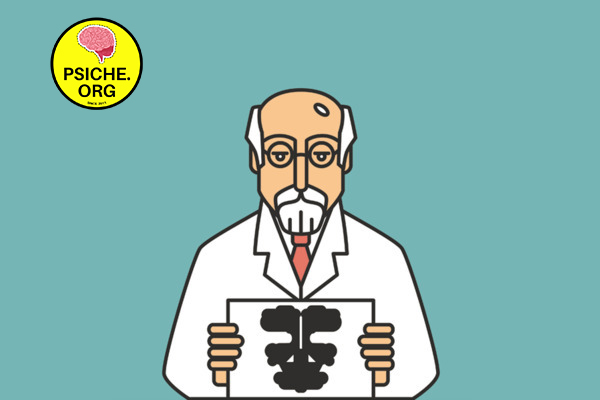Diagnosi: conoscere attraverso
Il dibattito che dura ormai dalla seconda metà del 900’ circa l’utilità e l’importanza della diagnosi psichiatrica trova le proprie fondamenta in due concezioni ben distinte (anche se non completamente non integrabili) della sofferenza psichica. Da un lato, la psichiatria di stampo biologista vede la diagnosi come il primum movens dell’intervento terapeutico. Ad ogni diagnosi corrisponde un trattamento mirato alla riduzione della sintomatologia osservata. Dall’altro lato, la psichiatria dinamica e fenomenologica considera la diagnosi non solo uno strumento utile (ma non sufficiente) per classificare e descrivere la sintomatologia osservata ma anche per cercare di comprendere in maniera esaustiva il vissuto psichico che accompagna quel particolare soggetto che arriva all’attenzione con un problema generatore di sofferenza. Negli ultimi anni, in particolar modo con l’introduzione del DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), abbiamo assistito al tentativo del superamento di un modello nosografico puramente descrittivo e categoriale nato negli anni 60-70’ che aveva come unico scopo quello di descrivere i pattern sintomatologici così come vengono osservati. In sostanza, ci si doveva basare solo ed esclusivamente sui sintomi così come appaiono all’occhio del clinico. Il nobile obiettivo di creare un sistema diagnostico a-teoretico e dunque svincolato da ogni influenza epistemologica (specialmente quella psicoanalitica che è stata predominante fino alla pubblicazione del DSM-III nel 1980), purtroppo è risultato un tentativo non perseguibile che ha generato una scollatura tra la nosografia e la realtà clinica con cui i professionisti della salute mentale devono confrontarsi quotidianamente (Migone, 2013). Per questo motivo, la task force che ha guidato lo sviluppo del DSM-5 ha proposto di introdurre, seppure all’interno della sezione 3 (Proposte di nuovi modelli e strumenti di valutazione), un modello dimensionale per i disturbi di personalità ma che può abbracciare anche tutte le altre tipologie di disturbi. Ciò implica un salto concettuale per il quale ogni disturbo non è più una categoria a sé stante e ben distinta l’una dall’altra ma, come la realtà clinica ci dimostra, ci possono essere forme di sofferenza talmente eterogenee da soddisfare i criteri per più di una diagnosi. Con un approccio puramente categoriale “Si formerebbero quindi “terre di nessuno” tra una diagnosi e l’altra, in cui collochiamo le forme ibride, atipiche o miste – le ben note diagnosi NAS (“non altrimenti specificate”) – che sono un po’ il “cestino dei rifiuti” di tutte le altre diagnosi. In altre parole, le diagnosi che non rientrano in alcuna categoria diventano esse stesse altre categorie, per cui non si presentano problemi di catalogazione.” (Migone, 2013, p. 572)
Non esiste nessun paziente che presenta esclusivamente una diagnosi “pura”. Ogni persona è un mondo unico ed irripetibile, non generalizzabile sulla base di criteri definiti aprioristicamente da studi statistici. Certamente la statistica è indispensabile sul piano sperimentale ma quando viene usata come unico strumento per validare la clinica e la psicopatologia annessa, allora dovremmo prestare molta attenzione a non cadere nel tranello (seppur attraente poiché rende tutto apparentemente comprensibile) del riduzionismo.
Invece di utilizzare la diagnosi come uno dei vari strumenti possibili che ci permette di creare un ponte tra il nostro modello conoscitivo e quello del paziente, spesso assistiamo ad una assolutizzazione estrema che ci porta ad un semplice ma irrimediabile errore clinico: tracciare una linea netta e lineare tra la diagnosi e il trattamento evidence based specifico che ci si aspetta avere una determinata efficacia senza tenere in considerazione che nel mezzo di queste due polarità, diagnosi e trattamento, si trova la soggettività della persona con tutte le sue peculiarità. La stessa etimologia della parola diagnosi (dal gr. διάγνωσις) che significa “conoscere attraverso” ci ricorda che non possiamo giungere ad una buona comprensione del fenomeno osservato senza attraversarlo nella sua soggettività.
Il fattore aspecifico
Ogni manifestazione psicopatologica che osserviamo necessita anche di mettere da parte i nostri meta-modelli conoscitivi per stare in maniera autentica con il paziente. È ormai verificato che il fattore aspecifico comune ad ogni modello psicoterapico sia il rapporto tra clinico e paziente (Wampold, 2001). Ciò che correla fortemente con il buon esito di un intervento terapeutico non è dunque la tecnica utilizzata ma una buona e sana relazione terapeutica. È il “rapport” tanto caro a Milton Erickson (1982) e definito come il fattore basale dell’esperienza ipnotica e terapeutica, il presupposto fondamentale per far funzionare gli innumerevoli strumenti psicoterapici che abbiamo a disposizione.
Dobbiamo “mettere tra parentesi la malattia mentale” sosteneva Husserl (1936). Con ciò, non si vuole sostenere l’idea quasi antipsichiatrica che non esista una psichiatria evidence based sennò tanto varrebbe avvalersi di stregoni e millantatori che molto spesso posseggono doti relazionali ed empatiche notevoli ma non sufficienti (per fortuna) per curare un disagio psichico. Abbiamo bisogno di modelli epistemologici fondati empiricamente e che siano efficaci nel trattamento ma che al tempo stesso possano essere rimodellati e adattati sulla base delle specifiche caratteristiche della persona che abbiamo di fronte. Applicare un protocollo definito aprioristicamente è semplice. Cercare di cucire in maniera sartoriale ogni intervento richiede tempo e creatività clinica.
Parentesi clinica e conclusioni
Un giovane ragazzo ricoverato in SPDC per un tentato suicidio, sembrava avere una velleità particolare per le diagnosi. Era solito chiedere delucidazioni circa il proprio funzionamento intellettivo e non solo. Leggendo i referti di alcune valutazioni effettuate in privato emergeva un profilo di plus-dotazione cognitiva. I dubbi diagnostici rispetto al profilo di personalità e anche al funzionamento intellettivo erano molteplici: si ipotizzava un possibile disturbo dello spettro autistico ma anche un disturbo di personalità del gruppo B e per non farci mancare niente anche un disturbo delirante. Effettuammo valutazioni neurocognitive, di personalità e di disturbo dello spettro autistico. Il ragazzo era un esempio lampante delle poli-diagnosi. Per aggirare le resistenze e lo stile manipolativo che il giovane aveva durante le valutazioni, si decise di effettuare il test di Roschach.
Ciò che emerse dai test fu certamente molto importante ai fini dell’impostazione del progetto terapeutico ma ciò che invece apprendemmo sul suo modo di stare in relazione con sè stesso e con il mondo non poteva essere racchiuso e spiegato esaustivamente dalla sola etichetta diagnostica. La sua appariva come una sofferenza esistenziale.
Questo è un esempio peculiare ma quante volte, soprattutto con pazienti che hanno un assetto di personalità disfunzionale, viene chiesto al clinico di dare un nome al proprio disagio con il tentativo di colmare quel sentimento cronico di vuoto che li porta a non sapere mai chi sono e a fluttuare tra mutevoli definizioni di sé.

Rossi Monti (2008) a tal proposito parla di “volatilità” dei sintomi riferendosi a quelle manifestazioni psicopatologiche che si osservano specialmente nei funzionamenti borderline e che con i nostri attuali sistemi di classificazione non siamo in grado di identificare sotto un unico ombrello. Sono sintomi che possono spaziare da fenomeni dissociativi come derealizzazione o depersonalizzazione fino ad attacchi di panico, pensieri interpretativi a carattere paranoideo o veri e propri episodi simil-deliranti. Ciò che questi sintomi hanno in comune è la loro temporaneità e aleatorietà. “i sintomi sono transitori: da pochi minuti a qualche ora. Il recupero (reale o anche solo immaginato) di una funzione di accudimento, andata perduta in seguito all’esperienza dell’abbandono (reale o o immaginato), determina una remissione dei sintomi[…] Non è possibile considerare questi sintomi come dati oggettivi, senza tenere conto del contesto (personologico e relazionale) in cui si realizzano (Rossi Monti, 2008, p. 75).
Sulla scia di questo irriducibile scarto tra la categorizzazione e la clinica, non è forse più terapeutico (ma certamente più complicato) provare a spiegare al paziente o alla paziente che piuttosto che dare un semplice nome o etichetta ai propri sintomi, è più importante entrarci dentro, conoscerli e provare a scoprire i numerosi “perchè” alla base del loro manifestarsi? Esplicitare la diagnosi, specialmente nel caso dei disturbi di personalità, può portare il soggetto ad autoalimentare la propria sofferenza deresponsabilizzandosi da ogni comportamento. “Io sono border! Ho questa grave malattia, per questo mi comporto così”. Sfortunatamente, essere border o soffrire di altre patologie mentali non è come avere una gamba rotta. Le cose sono assai più complicate, la psiche umana lo è e non possiamo prescindere da questo. Possiamo osservare lo stesso sintomo in più di un paziente ma il contenuto del pensiero non è mai lo stesso e ancor di più, il significato che il paziente attribuisce alla propria sintomatologia è qualcosa che appartiene solo ed esclusivamente a lui. La comunicazione della semplice “etichetta” diagnostica dovrebbe essere sempre accompagnata e andare di pari passo con un lavoro duale, tra clinico e paziente, di approfondimento e spiegazione delle dinamiche profonde che stanno dentro al “contenitore” diagnostico, dentro l’essere del paziente.
Un osservatore assoluto in grado di oggettivare le forme psicopatologiche non può esistere. “E’ tempo per gli scienziati [direi per la psichiatria clinica] di mettere l’oggettività tra parentesi” (Maturana , 1993). Ciò non significa rinunciare alla diagnosi dalla quale non possiamo esimerci ma significa trarre da essa l’utile che ci permette di coltivare il tentativo di comprendere cosa sente il paziente senza mai avere la presunzione di avere un “tutto” già preconfezionato. La diagnosi non è scolpita nella roccia. La diagnosi non la fanno i test ma la fa la clinica mi ripeteva spesso la mia tutor in clinica psichiatrica. Quando percepiamo di aver già compreso lo scibile, che la diagnosi spiega ogni comportamento della persona e che il trattamento che ha funzionato in passato con un’altra persona debba per forza funzionare anche adesso perché replicabile e “basato sulle evidenze”, vale la pena ricordarci che invece di indossare solo ed esclusivamente i nostri occhiali (costituiti per lo più da forme omologate di criteri nosografici), talvolta è indispensabile provare a mettersi anche quelli del paziente per cercare di vedere il mondo e la propria vita così come li vede lui.
Bibliografia
American Psychiatric Association. (2014). DSM – 5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Raffaello Cortina Editore.
Erickson, M. (1982). La mia voce ti accompagnerà. I racconti didattici . Roma, : Astrolabio Ubaldini.
Husserl, E. (1936). La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. (E. Paci, A cura di, & E. Filippini, Trad.) Milano: Il Saggiatore,2008.
Maturana , H. (1993). Autocoscienza e realtà . Milano: Raffaello Cortina .
Migone, P. (2013). Presentazione del DSM-5. Psicoterapia e scienze umane, XLVII(4), 567-600.
Rossi Monti, M. (2008). Forme del delirio e psicopatologia. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Wampold, B. (2001). The Great Psychotherapy Debate: Models, Methods, and Findings. Mahwah:NJ.: Lawrence Erlbaum Associates Inc.